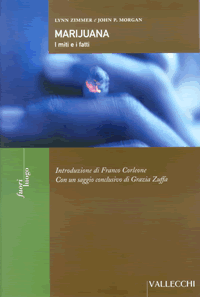 Giancarlo Arnao, il più noto antiproibizionista italiano, autore di numerosi testi su cui si è fondata la riflessione e la politica di numerose generazioni di studiosi e militanti, aveva commentato lo studio della sociologa Lynn Zimmer e del farmacologo John Morgan, che viene ora presentato in edizione italiana. Arnao sottolineava che nel lavoro di Zimmer e Morgan “tutte le argomentazioni che sono state portate per giustificare il proibizionismo della cannabis vengono sottoposte ad un confronto puntuale ed approfondito con la documentazione scientifica esistente”.
Giancarlo Arnao, il più noto antiproibizionista italiano, autore di numerosi testi su cui si è fondata la riflessione e la politica di numerose generazioni di studiosi e militanti, aveva commentato lo studio della sociologa Lynn Zimmer e del farmacologo John Morgan, che viene ora presentato in edizione italiana. Arnao sottolineava che nel lavoro di Zimmer e Morgan “tutte le argomentazioni che sono state portate per giustificare il proibizionismo della cannabis vengono sottoposte ad un confronto puntuale ed approfondito con la documentazione scientifica esistente”.
Lo scopo del volume, attraverso una ricca rassegna della letteratura scientifica circa le asserzioni sulla pericolosità della marijuana, è di mettere in luce le scorciatoie dialettiche usate da istituzioni come il NIDA (National Institute on Drug Abuse) finanziato dal governo degli USA, che invece di assolvere al suo ruolo scientifico, hanno assunto un ruolo propagandistico della “guerra alla droga”.
Gli autori di questo studio rifiutano la logica di forzare i dati per fomentare l’allarmismo, partendo, come notava Arnao, dall’assunto scientificamente inoppugnabile che la valutazione della “tossicità” delle cosiddette “droghe” non può essere assoluta: nel misurare l’impatto di una sostanza sui comportamenti e sulla salute di chi la usa, l’importante non è tanto appurare che tale sostanza sia genericamente “tossica”, quanto che possa esserlo nelle normali condizioni di consumo da parte degli esseri umani.
La ricca bibliografia costituisce un riferimento indispensabile per gli studiosi che vogliano approfondire la conoscenza degli effetti della cannabis.
Il volume è arricchito da una Appendice in cui Grazia Zuffa presenta le più recenti revisioni scientifiche e rapporti internazionali che, negli ultimi cinque anni, hanno suffragato le tesi di Zimmer e Morgan, contestando altresì le menzogne spacciate per verità scientifiche.
Siamo convinti che possa rivelarsi uno strumento utile per chi opera nel campo delle droghe e della tossicodipendenza. Vorremmo però che fosse meditato e utilizzato anche da chi è impegnato nell’ambito della politica delle droghe, specie chi ha la responsabilità di prendere decisioni legislative nel nostro Paese. Purtroppo abbiamo dovuto spesso constatare che questo problema è affrontato a prescindere dalla conoscenza fondata sulla scienza e sui dati oggettivi, e talvolta in evidente contrasto con essi.
Per comprendere ciò, è fondamentale rifarsi alla storia delle “leggende” sulla canapa, inestricabilmente intrecciata alle origini del proibizionismo. La demonizzazione della canapa, di cui fu il principale artefice Harry Aslinger negli anni ‘30, è destinata a sostituire egregiamente la demonizzazione dell’alcol, dopo il clamoroso fallimento di quella prima esperienza proibizionista[i]. Un castello di invenzioni e menzogne diffuse nel mondo e accreditate dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite, attraverso le Convenzioni internazionali del 1961, 1971 1988: i cui testi, per ragioni politiche, sono diventati immodificabili come un tabù. In tal modo la proibizione si svela per quello che è: non una modalità di governo di un problema sanitario e sociale, come tale soggetta a verifiche e aggiustamenti, bensì come una religione. Per dirla con Peter Cohen, “I trattati internazionali sulle droghe sono tra i testi più sacri della Chiesa della Proibizione delle droghe. I burocrati antidroga vengono assunti per la loro ortodossia religiosa e per la loro utilità per la Chiesa[ii]
Il sessantotto drogato
Cercherò dunque di ripercorrere le tappe della costruzione sociale della canapa come “flagello”, per la salute e (soprattutto) per la morale, a cominciare dal momento di prima diffusione di massa dei consumi fra la popolazione giovanile: gli anni ’70.
Alle scosse provocate dalla contestazione e dal movimento del ’68, nei paesi occidentali si era opposta una visione politica e culturale reazionaria che aveva creato un immaginario falsante del mondo giovanile, legato a una stigmatizzazione degli stili di vita, dell’abbigliamento, della lunghezza dei capelli. La criminalizzazione della canapa, quale consumo caratteristico di una generazione di giovani, è dunque strettamente intrecciata alla criminalizzazione di una intera generazione della “contestazione”.
Un testo fondamentale del 1971 sugli stereotipi del drogato che pervadono la società si deve a Jock Young [iii] Scrive il sociologo britannico: “Dobbiamo esaminare l’indignazione morale che il poliziotto manifesta nei confronti del drogato. C’è un conflitto reale tra i valori del poliziotto e i valori del bohémien fumatore di marijuana. Mentre il poliziotto apprezza una mascolinità rigida, il rinvio del soddisfacimento degli istinti, la sobrietà e la rispettabilità, il bohémien è fedele a valori che sono in rapporto con l’aperta espressività nel comportamento e negli abiti e con la ricerca del piacere indipendentemente dal lavoro, e anzi nel disprezzo del lavoro. Il bohémien in effetti minaccia la realtà del poliziotto. Vive senza lavorare, cerca il piacere senza rinviarne il soddisfacimento, stabilisce legami sessuali senza sottostare agli obblighi del matrimonio, si veste come vuole in un mondo in cui l’uniformità dell’abbigliamento è considerata come il distintivo dell’uomo rispettabile e degno di fiducia”.
Illuminanti i risultati di uno studio sui poliziotti americani operanti nel settore degli stupefacenti, riferito da Young. Invitati a definire le principali caratteristiche personali e sociali del consumatore di droghe, gli agenti parlavano perlopiù di “degenerazione morale”, “poca voglia di lavorare”, insicurezza e instabilità, orientamento al piacere, incapacità di affrontare i problemi della vita, personalità debole e inadeguata: il fumatore di marijuana era visto come una minaccia per la comunità più grave della mafia. “Il drogato suscita una immediata reazione viscerale, mentre per lo più i criminali vengono capiti subito, nei moventi come nel modo di vivere: perché il criminale si limita a barare allo stesso gioco che gioca anche il poliziotto, mentre il bohémien è scettico sulla validità del gioco in sé e quindi mette in dubbio la visione del mondo del poliziotto come del criminale”.[iv]
Young analizza inoltre la dialettica fra l’etichettamento “morale” del drogato, come vizioso e colpevole, e quello di “portatore di un problema sociale” (giudicato del tutto inesistente, nel caso del fumatore di marijuana): “In questo secolo, a causa di un onnipresente liberalismo, siamo restii a condannare un altro semplicemente perché si comporta diversamente da noi, purché non danneggi il prossimo. L’indignazione morale, dunque, e l’intervento negli affari di altri che giudichiamo malvagi devono essere per forza sostituiti dall’umanitarismo che, usando il linguaggio della terapia della guarigione, interviene per favorire ciò che considera l’interesse e il bene degli individui devianti.”
Tornando allo specifico della canapa, l’autore contesta la rappresentazione dei danni prodotti dalla chimica della sostanza, astraendola dal contesto della proibizione.“Secondo lo stereotipo – egli scrive- gli effetti della marijuana andrebbero dall’eccesso sessuale alla criminalità aggressiva e ai selvaggi episodi psicotici…ma è la marijuana fumata nel contesto della persecuzione poliziesca che suscita sensazioni di paranoia e provoca episodi semi-psicotici”.
Scrive sulla stessa linea Allen Ginsberg: “Non c’è da meravigliarsi se quasi tutti quelli che hanno fumato marijuana in America provano spesso uno stato di angoscia, di minaccia, di paranoia anzi, che può portare al tremore o all’isterismo, alla microscopica consapevolezza che si sta violando una legge, che migliaia di investigatori di tutto il paese vengono addestrati e pagati per scovarli e metterli in prigione, che migliaia di persone della loro comunità sono dentro, che inevitabilmente qualche amico è pizzicato con tutta l’ipocrisia e le spese e l’angoscia del processo e forse della punizione: prigione e persecuzione da parte della burocrazia che ha fatto la legge, l’ha propagandata, l’amministra e ne approfitta. In base all’esperienza mia e di altri sono arrivato alla conclusione che quasi tutti gli effetti e i disordini orripilanti che secondo il Bureau of Narcotics del dipartimento del Tesoro caratterizzerebbero l’‘intossicazione’ da marijuana sono esattamente il contrario, si possono cioè far risalire agli effetti che hanno sulla coscienza non lo stupefacente ma la legge e le minacciose attività del Bureau stesso. Così, come disse Buddha a una signora che gli offriva una maledizione, il dono ritorna al donatore quando non viene accettato”[v]
Anche i rischi dell’escalation, dalle droghe leggere a quelle pesanti, sono riformulati da Young in chiave sociale: “Per quali motivi non vogliamo che l’individuo fumi la marijuana? Perché: 1) la sostanza ha effetti fisicamente nocivi o porta a prendere sostanze fisicamente nocive; oppure perché: 2) provoca gravi disturbi della personalità; oppure perché: 3) porta a una condotta che è giudicata socialmente nociva? In riferimento a tutte e tre le domande, il rapporto della Commissione Wootton non vede, si direbbe, gravi pericoli nel fatto di fumare la marijuana, anche se sottolinea per prudenza che è necessario compiere ulteriori ricerche.[vi] La preoccupazione più pertinente della Commissione è l’ipotesi dell’escalation, secondo cui la marijuana sarebbe una tappa sul cammino dell’assuefazione all’eroina. Credo di avere chiarito il mio pensiero in proposito, e cioè che l’escalation è un fenomeno socio-culturale che, lungi dall’esserne impedito, è prodotto dai sistemi di controllo repressivi”.
In altri termini, la criminalizzazione di un comportamento che di per sé non produrrebbe eccessivi rischi per la salute, ha come grave controindicazione l’amplificazione della devianza, attraverso l’avvio del consumatore nel circuito criminale. Non solo. La condanna morale e/ la patologizzazione di ogni consumo di qualsiasi droga illegale ha l’effetto di assimilare l’uso di sostanze meno rischiose a quello di sostanze più rischiose. La proibizione cioè, con gli stereotipi che le fanno da contorno, amplifica, anziché ridurre i rischi del consumo di droghe: se non altro perché contrasta la diffusione di un’educazione all’uso più sicuro. Sarebbe meglio insomma valorizzare i controlli sociali, le subculture delle droghe e i saperi dei consumatori, “non illudendosi di controllare un’attività urlando che è proibita. È possibile che, alla lunga, – sostiene Young – la marijuana finisca col diventare una droga tollerata, se non proprio rispettabile. I tribunali arriveranno forse a considerare il possesso come un reato esclusivamente tecnico e a punirlo solo con piccole multe. Se questo modificherà la posizione del consumatore di marijuana non bohémien, non servirà a migliorare quella dello hippie. L’amplificazione della devianza del “dropout” non è infatti legata irrevocabilmente all’uso della marijuana. La società reagisce contro le culture edonistiche che ricorrono alla droga per assicurarsi un “piacere” immeritato; non reagisce contro la droga in sé: Può darsi perciò che un giorno l’avvocato e il commerciante fumeranno marijuana nelle ore libere. Quando questo succederà, la reazione contro l’hippie non sarà più espressa in rapporto all’uso della marijuana. Altre droghe forniranno il pretesto dell’intervento umanitario e non c’è dubbio che lo stesso bohémien apprezzerà molto meno la marijuana, in quanto il suo valore simbolico diminuirà”.
Il paternalismo umanitario in Italia
In Italia il dibattito si accende a metà degli anni Settanta, intorno alla critica alla legge allora in vigore, fortemente punitiva. Il movimento di opinione per la depenalizzazione del consumo, amplificato dalle iniziative di disobbedienza civile di Marco Pannella, porta all’approvazione della legge 685 del dicembre 1975. Pur mantenendo l’impianto della proibizione, la nuova normativa introduce la “non punibilità” dell’uso della “modica quantità” di sostanze psicoattive. Ciò significa distinguere la figura dello spacciatore da quella del consumatore rinunciando a punire quest’ultimo per avviarlo al circuito terapeutico/riabilitativo. La 685 è chiaramente ispirata alla rappresentazione della droga come “problema sociale”, di cui parla Young. Il mutamento di paradigma è sollecitato anche dalla diffusione dei consumi di canapa, e dal tentativo di contenere la criminalizzazione indiscriminata di questi giovani consumatori operata dalla legge del ’54 [vii] Nel 1976 apparve un saggio dello psichiatra Giovanni Jervis, che affronta il tema delle droghe leggere[viii]. Lo psichiatra sottolinea “il peso grandissimo di valori e di stereotipi culturali, di pregiudizi e di convinzioni, di certezze non dimostrabili, di ribellioni profonde, di atteggiamenti irrazionali, sia nel costituirsi della ideologia dominante della droga, sia anche nelle ideologie controculturali”.Insomma, l’immagine pubblica delle droghe è mistificata e confusa a causa di una classificazione e separazione categorica e irrazionale fra droghe lecite e droghe proibite. Se la tossicità delle droghe leggere sembra essere molto scarsa, almeno alle dosi usate da quasi tutti i consumatori, ciononostante l’immagine mitica della “droga” si impone, in contrasto con l’esperienza storica e le evidenze scientifiche.
“L’ideologia dominante- spiega Jervis- ha queste caratteristiche principali: è stabilita, diffusa, resa egemonica da chi non ha mai introdotto nel proprio organismo ‘droghe’ né leggere né pesanti (a parte le droghe lecite come l’alcool), e non sa neppure bene che cosa siano; non fa sostanzialmente differenza fra le leggere e le pesanti; non considera droga né l’alcool né – eventualmente con qualche eccezione – gli psicofarmaci; serve di fatto gli interessi dello stato e del capitale; incrementa la diffusione dell’eroina. L’ideologia dominante della droga ha creato e diffuso del ‘drogato’ un’immagine particolare, soprattutto dove è mancato negli anni Sessanta un forte movimento controculturale giovanile. Per quasi tutti, l’immagine del drogato si identifica in pratica con quella del capellone pittoresco, squattrinato e vagabondo. Mediante l’identificazione ‘drogato=giovane studente losco, sporco, sfaccendato e marginale’ è scattata in Italia l’operazione repressiva”.
Dunque, anche per Jervis, come per Young, l’illegalità della canapa è uno strumento per etichettare negativamente i movimenti giovanili. Ma è vero anche il contrario: lo stile di vita outsider dei più affezionati adepti della canapa contribuisce al “discredito” della sostanza, rea di dare piacere e di incentivare molti altri piaceri. Da qui all’idea della droga come contagio sociale, il passo è breve. “Per l’ideologia dominante, ‘la droga’ non è affatto riducibile a un insieme di sostanze chimiche: è piuttosto un virus, una infezione contagiosa; anzi, più che questo, uno stato di possessione. Di fatto, il concetto di possessione demoniaca nell’occidente cristiano costituisce il precedente storico più significativo dell’attuale ideologia della droga. La possessione era identificata come uno stato psichico a cui veniva attribuita la capacità di espropriare totalmente la volontà del soggetto”
Insomma, il rifiuto della “droga”, come viene manifestato abitualmente, ha con ogni probabilità radici profonde, quasi ancestrali.
Anche Giancarlo Arnao in un articolo dal suggestivo titolo La grande mistificazione, così descrive acutamente il groviglio concettuale in cui ancora oggi ci dibattiamo[ix]:
“L’idea del contagio – felicemente affermatasi nel linguaggio giornalistico: ‘l’epidemia della droga’! – suggerisce che la ‘malattia’ dell’uso di droga possa trasmettersi ‘per contatto’ anche se è noto che non è propagata da un agente batterico (…) da una parte è censurato come abitudine viziosa e degradante, dall’altra viene descritto come qualcosa che è strettamente collegata con il piacere, l’ozio, il sesso, il gioco. L’ambiguità dello stereotipo morale risulta evidente anche in alcune definizioni convenzionali dell’uso di droga, come ‘evasione dalla realtà’ e ‘paradisi artificiali’: queste espressioni, – nel contesto di una società che incoraggia e istituzionalizza l’evasione di massa (sport-spettacolo, televisione, ecc.), dove l’artificiale prende progressivamente il sopravvento sul naturale, dove pochi ancora credono in un reale paradiso – non sembrano dotate di un grande potere di dissuasione, e danno nello stesso un’immagine magica della droga, come di uno strumento per la trasformazione della realtà”.
Gli strali di Jervis si appuntano anche contro l’immagine del drogato come “vittima sociale”, che in certa misura ispira la riforma del ’75, come si è detto. Se è vero che per le droghe è ancora dominante l’intollerante indignazione, tuttavia il “paternalismo umanitario”, fiorente nei confronti del ricoverato manicomiale, si sta estendendo al “drogato”, commenta l’autore. Col risultato di introdurre “l’immagine del tossicomane come di un soggetto che va difeso contro se stesso; ed è inevitabile qui il disprezzo (appena nascosto da uno strato di bontà cristiana tradizionale, opportunamente laicizzata) per chi, a differenza di colui che esprime il giudizio, non si è saputo gestire e ora è vittima di un destino maligno. Qui non c’è salvezza senza pentimento, ravvedimento, adesione ai valori dominanti, e riconoscenza; non c’è redenzione senza un itinerario pedagogico che la prepari; la cura richiede che il malato si infantilizzi, e il curante sparga su di lui (ed esibisca ai quattro punti cardinali) il suo impegno vocazionale – e la sua abnegazione – di liberatore”.
Da qui il giudizio drastico sulla nuova legge, definita illiberale, psichiatrizzante e, addirittura, un vero inganno.
Gli anni ’90, fra tolleranza e solidarismo autoritario
Il “paternalismo umanitario”, così severamente criticato da Jervis ha trovato in Italia un terreno particolarmente fertile per attecchire, sia nelle componenti cattoliche che in larghi settori della sinistra storica. Non è qui il luogo per addentrarsi nella complessa disanima delle culture politiche del nostro paese. Basti osservare che nella dialettica dei poli individuo/collettivo, per le concezioni che sottolineano fortemente il secondo, lo scivolamento paternalista è sempre in agguato. Così, nella sinistra, l’azione sociale, destinata in origine a sostenere la libertà dei singoli, può sfociare nella sostituzione della responsabilità collettiva a quella individuale, in vista di un “bene” sociale sovradeterminato[x] D’altro lato, la retorica “umanitaria”, che vorrebbe salvare l’individuo da se stesso, permette di lasciare pressoché inalterata l’immagine della droga come “perdizione” (del corpo ma anche dell’anima). In altri termini, l’immagine del drogato “vittima” rafforza l’esecrazione (morale) verso la droga, senza scalfire l’impalcatura proibizionista.
Si comprende allora perché il tema delle droghe leggere abbia avuto sempre difficoltà ad entrare nell’agenda politica del paese: da un lato, il consumatore di canapa non è il più adatto a stimolare “l’abnegazione dei liberatori”, per dirla ancora con Jervis; dall’altro, le culture liberali/libertarie hanno sempre avuto un peso limitato nel panorama italiano.
Ciò è testimoniato dalla svolta punitiva del 1990, sollecitata dal partito socialista: è Bettino Craxi, sull’onda di una campagna subalterna alla politica della tolleranza zero di derivazione statunitense, a imporre il ripristino delle sanzioni penali per il consumo personale delle sostanze stupefacenti. Svolta tanto più significativa perché sino ad allora i socialisti si era riconosciuti nello schieramento libertario (minoritario) della sinistra, e avevano sostenuto la legalizzazione delle droghe leggere.
Una forza politica in precedenza orientata nella difesa e nella promozione dei diritti civili subì così una torsione drastica a favore di una impostazione etica, di una didattica del divieto e della cura coatta. La polemica di Craxi assunse toni particolarmente duri contro i sostenitori del cosiddetto “club della modica quantità”. In quel clima fu sancito il principio della illiceità assoluta del consumo di tutte le sostanze con l’approvazione di una specifica norma-manifesto.
Gli effetti della svolta punitiva non tardarono a farsi sentire. Il numero dei detenuti subì un’impennata da trenta a cinquantamila presenze nelle carceri italiane e l’arresto (obbligatorio) di tanti giovani per possesso anche di piccole quantità di canapa in troppi casi si trasformò in tragedia. Infatti alcuni giovani colpiti dalla repressione, non ressero alla vergogna e si suicidarono.
La protesta sociale portò ad alcune urgenti modifiche della legge e alla raccolta delle firme per un referendum abrogativo che si svolse nella primavera del 1993.
Il voto netto e non equivoco dei cittadini abrogò le norme più odiose di quella legge nota come DPR 309/90 e depenalizzò la detenzione di sostanze per uso personale, restituendo ai medici la potestà delle scelte terapeutiche.
Il risultato del referendum non determinò semplicemente il ritorno alla situazione precedente di non punibilità per il consumatore, ma produsse un asse culturale nuovo con l’affermazione delle politiche di riduzione del danno e del principio rimasto troppo spesso sulla carta della depenalizzazione del consumo. In questo quadro si configurava anche una maggiore tolleranza sociale verso gli usi e i consumi, gli stili di vita dei giovani e in particolare l’uso ricreativo della canapa.
Questa tendenza si è sviluppata in molti paesi europei, non lasciando più isolata l’Olanda nella pratica dei coffee-shops. Ma la reazione dell’Agenzia antidroga dell’Onu, l’UNDCP e del suo braccio armato l’INCB (International Narcotic Control Board) è stata violenta utilizzando una potenza di fuoco inaudita. I rapporti annuali dell’INCB confermano la resistenza tetragona a ogni tesi innovativa e in particolare l’esistenza di una vera e propria ossessione verso la canapa denunciando “la falsa percezione fra i giovani che questa droga sia innocua” e attaccando i paesi orientati alla decriminalizzazione. Secondo l’INCB, infatti “ introdurre una distinzione fra droghe leggere e pesanti, implica l’esistenza di un uso sicuro di una droga come la cannabis”.
Il 9 giugno del 1998, si svolse l’assemblea straordinaria delle Nazioni Unite organizzata da Pino Arlacchi, allora capo della Agenzia antidroga dell’Onu, che lanciò l’obiettivo ambizioso di “un mondo senza droga” da raggiungersi entro 10 anni..
All’interno del Palazzo di Vetro in cui si tenne l’assise, un fantasma si aggirava a turbare la falsa coscienza dei molti sepolcri imbiancati: la marijuana. L’oppio e la coca, con la rituale demonizzazione evocatrice del “flagello” per i giovani, in realtà servono da alibi per attaccare il vero nemico, costituito dalla cannabis.
Furono allora indicate due tappe, il 2003 e il 2008 per la verifica del successo o del fallimento della strategia. Dopo cinque anni il primo appuntamento a Vienna si è tenuto sotto la guida di Antonio Costa. Nonostante l’evidente fallimento dell’operazione demagogica di “liberazione dalla droga”, pur in presenza di un sostegno politico generalizzato e con l’impiego di risorse economiche straordinariamente rilevanti, i “guerrieri della droga”, hanno rilanciato la sfida chiedendo più soldi e più tempo, sapendo che non potranno vincere la guerra insensata che hanno dichiarato. Trattandosi di una guerra simbolica, del Bene contro il Male, contano sul fatto che le manipolazioni potranno durare all’infinito evitando di imboccare la strada ragionevole della sperimentazione sociale e continuando a perseguire gli interessi di autoconservazione di una narcoburocrazia senza scrupoli, nel segno di un miraggio salvifico.
È proprio a Vienna, in quella sede di confronto internazionale, che Gianfranco Fini annunciò una svolta di 180 gradi della politica italiana sulle droghe in nome del proibizionismo più oltranzista.
Così, ancora una volta l’Italia si avvia sulla strada scivolosa di una “nuova” legge sulla droga che ripercorre i sentieri già battuti nel 1990 anche se il sottosegretario Mantovano, vero ispiratore della legge secondo i canoni della sua cultura integralista, ha avuto modo di scrivere con ammirevole faccia tosta sul “Corriere della Sera” del 2 dicembre 2003 che “la libertà della droga è già stata sperimentata e ha fallito”. L’ex direttore Paolo Mieli gli ha replicato seccamente: “Tenderei a escludere che in Italia sia mai stata sperimentata, non dico la libertà ma anche solo la legalità della droga. Sono anni che lo Stato insiste a proibire anche le sostanze leggere. Infine fa sorridere, mi creda, il tentativo di riversare la colpa di ogni calamità in questo campo su quel (peraltro disatteso) referendum del 1993”.
La canapa come “capro espiatorio”
E’ utile uno sforzo per comprendere il motivo profondo della scelta di criminalizzare ancora di più la cannabis.
Lo sviluppo dei consumi di “erba” per tutti gli anni ’90, con caratteristiche di “droga ricreativa” e dimensioni intergenerazionali e interclassiste, ha portato a una sorta di “normalizzazione” della sostanza che avrebbe dovuto depotenziare lo scontro ideologico.
In realtà, la “pianta maledetta” continua ad assolvere il ruolo di capro espiatorio, anche se ha sviluppate potenzialità terapeutiche e curative.
Perché dunque una pianta usata da migliaia di anni e presente nella farmacopea occidentale del XIX secolo, continua ad essere il bersaglio preferito dalla repressione proibizionista?
Nonostante il primo rapporto medico sulla cannabis sia stato pubblicato nel 1894 da parte della Commissione governativa Anglo-Indiana, in cui si sosteneva in ben 3281 pagine la non pericolosità dell’uso di cannabis, si continuano a produrre ricerche che non modificano sostanzialmente quel primo giudizio.
Così la prestigiosa rivista medica “The Lancet”[xi], con un editoriale dal titolo Smitizzare la cannabis affermava che “il fumo della cannabis, anche per lungo periodo, non fa male alla salute” e si pronunciava a favore di una legalizzazione e di una soluzione pratica simile al modello olandese dei coffee-shop.
Per trovare conferma della situazione di paradosso esasperato, vale la pena ricordare che il Senato canadese ha approvato nel 2002 un Rapporto di uno speciale Comitato presieduto dal senatore Pierre Claude Nolin le cui conclusioni ricalcano quelle di un precedente studio della Commissione governativa del Canada del 1972 che aveva proposto la depenalizzazione del possesso e della coltivazione di cannabis per uso personale.
Tutte le soluzioni si infrangono però contro il tabù creato dalle Convenzioni internazionali dell’Onu che hanno imposto una Crociata al mondo, minacciando scomuniche seppure senza valore e prive di conseguenze per i paesi disertori.
La “war on drugs” si regge su un mito salvifico, su un dogma costituito dal potere assoluto della sostanza che rende la persona vittima e incapace di intendere e di volere, malato o criminale e, ancora peggio, vizioso.
Una logica di tal fatta, che non riconosce l’esistenza di un consumo consapevole, che non ammette soggettività e capacità di scelta autonoma, rappresenta un universo concentrazionario che non può tollerare la categoria della distinzione.
I “guerrieri” temono che se si accettasse una diversa regolamentazione per la cannabis, si dovrebbe giustificare l’origine del proibizionismo e il cumulo di menzogne costruite nei decenni.
La ragione dell’attacco costante che i documenti dell’INCB rivolgono alle politiche tolleranti dei paesi europei, attraverso una campagna che rasenta i toni goebbelsiani, risiede nel timore che anche una leggera smagliatura faccia crollare miseramente l’intero edificio.
L’ultima trincea, rafforzata negli anni recenti anche attraverso scoop giornalistici, è fondata sul terrorismo della pretesa maggiore quantità di principio attivo presente nella cannabis in circolazione, che causerebbe perciò danni irreparabili al cervello dei giovani. Anche dove e quando ciò fosse accertato, questo è semmai appunto uno degli effetti del proibizionismo. La frontiera del salutismo è eretta per difendere l’ortodossia dei sacerdoti delle burocrazie sclerotizzate contro i cittadini preoccupati da “tutto ciò che fa male”.
Le campagne anti-fumo per convincere sui danni del tabagismo hanno privilegiato messaggi dal taglio drastico e ultimativo; va però ricordato che il professor Umberto Veronesi propugnatore dell’utilità della campagna stessa, ha messo in guardia dal rischio di scivolare nel proibizionismo.
Sono quindi convinto, parafrasando il titolo di questo volume, che “il mito della canapa”, rischia di essere rafforzato proprio dalle campagne che descrivono questa pianta come il nemico assoluto, e non scomparirà mai e che anzi si accrescerà a dispetto dei miti, cioè delle falsità, spacciati a piene mani.
Per una opzione liberale
Ciò che va ridotto è invece il danno della politica.
Gianfranco Fini si presenta come l’alleato più fedele degli Stati Uniti nella costruzione di una sorta di “pensiero unico”, che si traduce in una terribile “guerra preventiva” contro i coltivatori nei paesi produttori e in una feroce repressione dei consumatori nei paesi del nord del mondo.
La proposta del leader di Alleanza Nazionale avrebbe conseguenze pesanti e incalcolabili in primo luogo per le garanzie e i diritti del cittadino. Garantismo e giusto processo sarebbero schiacciati dalle condanne per spaccio presunto e non dimostrato.
Sulla base dell’assioma antiscientifico che non esisterebbero differenze tra le sostanze e dell’assunto ideologico che “la droga è droga”, nel disegno di legge governativo si propone l’unificazione delle attuali sei tabelle, in cui sono classificate le sostanze psicotrope, in una sola. L’effetto e l’intenzione è di prevedere pene indifferenziate per la detenzione di qualunque sostanza, dall’eroina alla canapa, dalla cocaina alla salvia divinorum. Basterà poi superare di un milligrammo il tetto previsto, per essere condannati come spacciatori con il carcere da sei a venti anni di pena.
Se già oggi metà dei detenuti presenti nelle carceri italiane lo sono per reati comunque ascrivibili alla legge sulle droghe, domani si raddoppierebbero e assisteremmo a una crudele macelleria sociale e all’esplosione del sistema giustizia e all’implosione della macchina giudiziaria.
I dati del 2003 sulla repressione sono eloquenti. La canapa è la sostanza più perseguitata: le operazioni antidroga per tipologia di sostanze vedono prevalere quelle contro la Cannabis con 9035 operazioni, rispetto alla Cocaina con 5100; all’Eroina con 3475; agli Amfetaminici con 436; all’LSD con 7; e infine a tutte le Altre sostanze con 357.
Le persone di nazionalità italiana deferite all’Autorità Giudiziaria nel 2003 per piccolo spaccio sono state 8483 per cannabis, 5651 per cocaina, 3514 per eroina, 10 per LSD. Quelle con provvedimento restrittivo sono state 3272 per cannabis, 1099 per cocaina, 672 per eroina e solo 4 per LSD.
Circa le segnalazioni al Prefetto per semplice consumo di sostanze (con il rischio di subire sanzioni amministrative, che nella proposta del Governo verrebbero ulteriormente aggravate), i numeri confermano la persecuzione contro lo spinello. Infatti, nel 2000 su 31.264 segnalazioni 27.872 riguardano cannabinoidi; nel 2001 su 30.051 segnalazioni ben 27.319 riguardano cannabinoidi; nel 2002 su 26.321 segnalazioni addirittura 23.731 riguardano cannabinoidi; infine, nel 2003 su 17.396 segnalazioni 15.029 riguardano cannabinoidi.
Rispetto al dibattito politico e culturale degli anni Settanta e anche di quello degli anni Novanta, oggi in Italia possiamo constatare che si è fatta una notevole chiarezza.
La divisione non si pone più su un piano ideologico tra pretesi solidaristi da una parte e liberisti senza cuore dall’altra, ma si è affermata una cultura del diritto svincolato dalla morale: quindi la differenziazione si pone tra chi vuole affermare le proprie concezioni morali o “salutiste” attraverso la forza del codice penale e chi invece vuole affermare le proprie convinzioni attraverso il confronto razionale e non coercitivo.
La sinistra ha abbandonato alcune posizioni del passato, come ad esempio il giudizio sul disvalore dell’uso di droga, e ha assunto il principio del diritto penale minimo e della concezione dello stato sociale di diritto in nome di un welfare rinnovato.
La destra di regime è attratta inevitabilmente dal richiamo del motto “legge e ordine”, inteso come carattere identitario cancellando qualunque suggestione culturale legata alle esperienze futuriste, mistiche o esoteriche[xii] e conferma quindi l’attaccamento a una sorta di filosofia dello stato etico che pretende di imporre i propri valori con il carcere o con la cura coatta in una rinnovata logica istituzionale manicomiale travestita da comunità.
Il pensiero liberale di John Stuart Mill è ancora e finalmente la misura di una società laica che non confonde piani diversi e che non ha paura del sentimento dell’umanità e della ricerca della felicità. “L’unica ragione per cui il potere è legittimamente autorizzato ad usar la forza contro un membro di una civile comunità, è quello d’impedire che nuoccia agli altri. Il bene, tanto fisico che morale di questo individuo, non è una giustificazione sufficiente. Nessuno può essere costretto a fare o non fare qualche cosa per la ragione che sarebbe meglio per lui, o perché quella cosa lo renderebbe più felice, o perché nella mente dei terzi ciò sarebbe saggio, od anche giusto. Possono essere queste buone ragioni per fargli qualche rimostranza, per ragionarne con lui, per persuaderlo e per pregarlo, ma non per costringerlo suo malgrado, o recargli alcun male quando agisca altrimenti. La coazione con è giustificata se non allorché si ritiene che la condotta di un individuo porti danno ad un altro. L’uomo non deve rispondere verso la società se non delle cose che possono concernere i terzi: per quello che non interessa che lui, la sua indipendenza è di diritto assoluta. Sopra se stesso, sul suo corpo, e sul suo spirito l’individuo è sovrano.”[xiii]
Occorre spezzare il cerchio magico che produce intolleranza verso il diverso, esclusione sociale ed emarginazione, perseguendo al contrario l’obiettivo di una società della ragione e del dialogo.
E’ davvero tempo che l’invocazione di Thomas Szasz [xiv] perché cessino le persecuzioni rituali di capri espiatori rappresentati dai drogati nelle nostre società moderne, laiche, impregnate dell’ideologia terapeutica, attraverso Crociate, Inquisizioni, Soluzioni definitive o Guerre contro la Droga, sia accolta.
Franco Corleone
[i] Cfr. Guido Blumir (2002), Marijuana.Uno scandalo internazionale, Einaudi, Torino
[ii] Peter Cohen (2003), “la caduta del dogma”, in Fuoriluogo, maggio 2003
[iii] Jock Young (1971), “The role of police as amplifiers of deviance”, in Stanley Cohen, a cura di, Images of deviance, Penguin . Il testo è tradotto e pubblicato nella rivista “Comunità”, numero 168, dicembre 1972).
[iv] Lo studio sui poliziotti americani e la loro immagine dei drogati è di R.Blum (1965), Utopiates, Tavistock Publications, Londra
[v] Allen Ginsberg (1968), “First Manifest to end the Bringdown”, in D.Soloman (ed), The Marijuana Papers, Signet Books, New York)
[vi] Il rapporto Wotton (1969)(Advisory Committee on Drug Dependence, Cannabis, HMSO, Londra), chiamato a esaminare la controversia sulla canapa, conclude che “la canapa non è una droga molto dannosa”. Cfr. p.
[vii] Per un’analisi puntuale del testo, rimando al commento di Arnao (Giancarlo Arnao, 1976, “Nuova legge sulla droga: ambiguità e repressione”, in Sapere, n.790, aprile 1976)
[viii] Giovanni Jervis (1976), “L’ideologia della droga e la questione delle droghe leggere”, in Quaderni Piacentini, n.58/59.
[ix] Giancarlo Arnao (1975), “La grande mistificazione”, in Sapere, n.785, agosto/settembre 1975
[x] Cfr. Grazia Zuffa (2000), I drogati e gli altri, Sellerio, Palermo, p.100 e sgg.
[xi] Cfr. The Lancet, numero 8985 dell’11 novembre 1995
[xii] Cfr. Luciano Lanna e Filippo Rossi, Fascisti immaginari, Vallecchi 2003, pag.98 e sgg.
[xiii] Cfr. Giovanni Sturt Mill, La Libertà, con prefazione di Luigi Einaudi, Piero Godetti editore, Torino, 1925, pag. 13
[xiv] Cfr. Thomas Szasz, Il mito della droga, Feltrinelli, 1977




